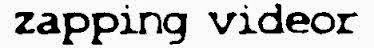L'aspetto forse più curioso di qualsiasi tipo di interfaccia digitale, appartenga a un particolare sistema operativo o a un'applicazione specifica, è che essa cerca di rappresentare nel proprio spazio operativo la presenza del visitatore. Qui ricomincia la storia, o per meglio dire, il dramma, del lettore, che non è più un «tu» come voleva Calvino, ma un «id», un vettore, un segno, la presenza oggettivata in fabula di un personaggio ridotto ai minimi termini. Dopo la diffusione universale delle due più geniali invenzioni di Douglas Engelbart, la finestra e il mouse,1 questa presenza minimale si è ulteriormente complicata: il visitatore si trova rappresentato in due forme, diviso nei due segni mobili del cursore e del puntatore. Ovvero viene scomposto nelle sue due componenti essenziali: atto e potenza, stasi e processo. Il puntatore, che muta di forma, che è sensibile agli oggetti che incontra e li trascina in qualche morbida trasformazione, rappresenta la nostra distanza, il poter fare e il saper fare, il ricercare, l'esser fuori. Il cursore, che lampeggia pedissequo, o che evidenzia un oggetto facendolo diventare blu – colore cristianamente spirituale, ma giottescamente reale – mostra dove siamo, non dove potremmo essere, quale oggetto abbiamo sotto mano e non come potremmo usarlo. Rappresenta il nostro essere dentro, la nostra «località» virtuale, il nostro lasciar segno ed essere segno.
In un certo senso cursore e puntatore sono le due metafore del nostro duplice modo di usare il computer, che è costitutivamente, e indissolubilmente, esperienziale e riflessivo, immersivo e indiretto. Diversi studiosi, con definizioni e prospettive differenti,2 hanno indicato questa duplice modalità di partecipazione al mondo digitale: l'interattività può essere immediata, plastica, corporea, mimetica, e quindi richiamare a una sorta di unità di tempo, di luogo e di azione che coinvolge emotività, propriocezione, decisione; oppure disporsi su molti piani, dividersi in tempi, spazi e intenzionalità differenti. In quest'ultimo caso diviene asincrona, acquista distanza, si rende molteplice, e implica scelte e dimenticanze, interruzioni e divagazioni, attese e ritorni.
Nello strumentario digitale ci sono infatti, a vari livelli, molti altri simboli, segni o sintomi dell'essere–dentro e dell'essere–fuori. Basti pensare allo schermo e alle finestre: un quadro che include altri quadri. Lo schermo è un vecchio sistema di incorniciamento, che ha ereditato alcune delle forme e delle funzioni del quadro dipinto. Delimita e rappresenta uno spazio altro in una superficie bidimensionale e in una scala differente rispetto allo spazio ospitante.3 Con il cinema lo schermo si trasforma: pretende di sostituirsi allo spazio ospitante, cresce di dimensione, diventa dinamico, e risucchia l'attenzione. L'idea è ora che sullo schermo accada qualcosa, che vi abbiano luogo eventi. Con la televisione quella superficie divenuta mobile e attraente ridiventa privata, ridiventa «da camera». Con il computer, infine, diviene un luogo dove il privato può rovesciarsi in pubblico e viceversa, in una specie di osmosi carnevalesca. Ma sempre, in tutte le sue metamorfosi, lo schermo mantiene i caratteri di bordo, di soglia, di confine, di porta esterna, di stipite che ricorda a chi lo guarda di essere fuori. Dello schermo del computer possiamo regolare la risoluzione senza necessariamente influire sulla costituzione digitale di ciò che esso mostra, scegliendo tra le modalità pittoriche del «ritratto» e del «paesaggio». E inoltre lo schermo espone le interfacce, incornicia le cornici. La finestra invece è inclusa, è dentro: quando è in primo piano, e attiva, rappresenta il visitatore non meno del cursore, ma ritagliandone lo spazio operativo sullo schermo. La finestra è un cursore «di area», inventato per permettere la compartecipazione e la condivisione di uno stesso ambiente da parte di più persone. Ha più del corridoio, in realtà, che della finestra: può contenere entrate, strumenti e oggetti, dà accesso a un interno ulteriore, anche quando si fa luogo di un dialogo con un altro computer e con le persone che ci stanno dietro, o quando permette un accesso remoto, che è sempre un entrare, un logging in. E di fatto ci si può imbattere, in certe modalità d'uso, come ad esempio la chat, nel cursore altrui.
I rapporti tra queste due semi–entità, tra queste due modalità d'essere, in realtà, non sono che l'epifenomeno di una complessità profonda, che non si mostra in superficie, ma di cui la superficie è in un certo senso la prova di verità. La superficie sembra più importante dei «dati» non per meri motivi di usabilità e di comunicazione, ma per motivi di strutturazione cognitiva, di inveramento e uso culturale di quei dati. Le superfici si moltiplicano, e si fanno struttura, racconto, argomentazione, schedario e teatro.
In un certo senso cursore e puntatore sono le due metafore del nostro duplice modo di usare il computer, che è costitutivamente, e indissolubilmente, esperienziale e riflessivo, immersivo e indiretto. Diversi studiosi, con definizioni e prospettive differenti,2 hanno indicato questa duplice modalità di partecipazione al mondo digitale: l'interattività può essere immediata, plastica, corporea, mimetica, e quindi richiamare a una sorta di unità di tempo, di luogo e di azione che coinvolge emotività, propriocezione, decisione; oppure disporsi su molti piani, dividersi in tempi, spazi e intenzionalità differenti. In quest'ultimo caso diviene asincrona, acquista distanza, si rende molteplice, e implica scelte e dimenticanze, interruzioni e divagazioni, attese e ritorni.
Nello strumentario digitale ci sono infatti, a vari livelli, molti altri simboli, segni o sintomi dell'essere–dentro e dell'essere–fuori. Basti pensare allo schermo e alle finestre: un quadro che include altri quadri. Lo schermo è un vecchio sistema di incorniciamento, che ha ereditato alcune delle forme e delle funzioni del quadro dipinto. Delimita e rappresenta uno spazio altro in una superficie bidimensionale e in una scala differente rispetto allo spazio ospitante.3 Con il cinema lo schermo si trasforma: pretende di sostituirsi allo spazio ospitante, cresce di dimensione, diventa dinamico, e risucchia l'attenzione. L'idea è ora che sullo schermo accada qualcosa, che vi abbiano luogo eventi. Con la televisione quella superficie divenuta mobile e attraente ridiventa privata, ridiventa «da camera». Con il computer, infine, diviene un luogo dove il privato può rovesciarsi in pubblico e viceversa, in una specie di osmosi carnevalesca. Ma sempre, in tutte le sue metamorfosi, lo schermo mantiene i caratteri di bordo, di soglia, di confine, di porta esterna, di stipite che ricorda a chi lo guarda di essere fuori. Dello schermo del computer possiamo regolare la risoluzione senza necessariamente influire sulla costituzione digitale di ciò che esso mostra, scegliendo tra le modalità pittoriche del «ritratto» e del «paesaggio». E inoltre lo schermo espone le interfacce, incornicia le cornici. La finestra invece è inclusa, è dentro: quando è in primo piano, e attiva, rappresenta il visitatore non meno del cursore, ma ritagliandone lo spazio operativo sullo schermo. La finestra è un cursore «di area», inventato per permettere la compartecipazione e la condivisione di uno stesso ambiente da parte di più persone. Ha più del corridoio, in realtà, che della finestra: può contenere entrate, strumenti e oggetti, dà accesso a un interno ulteriore, anche quando si fa luogo di un dialogo con un altro computer e con le persone che ci stanno dietro, o quando permette un accesso remoto, che è sempre un entrare, un logging in. E di fatto ci si può imbattere, in certe modalità d'uso, come ad esempio la chat, nel cursore altrui.
I rapporti tra queste due semi–entità, tra queste due modalità d'essere, in realtà, non sono che l'epifenomeno di una complessità profonda, che non si mostra in superficie, ma di cui la superficie è in un certo senso la prova di verità. La superficie sembra più importante dei «dati» non per meri motivi di usabilità e di comunicazione, ma per motivi di strutturazione cognitiva, di inveramento e uso culturale di quei dati. Le superfici si moltiplicano, e si fanno struttura, racconto, argomentazione, schedario e teatro.
Se nello spazio attivo di quelle superfici i due aspetti che si sono descritti convivono, ovvero se nel nostro uso del computer si alternano stati e processi, se la nostra presenza si divide e si contempera, se usiamo dispositivi di entrata, di uscita, di collegamento, di determinazione spaziale, di scelta di opzioni, di interrogazione, di bricolage, siamo già all'interno di ciò che si può definire, in senso ampio, ipertesto. Qui si propone l'ipotesi che l'ipertestualità, e non il database, sia la modalità dominante, o, per meglio dire, modellizzante del mondo digitale nel suo complesso.4 La strutturazione e la configurazione ritmica, spaziale, simbolica e pragmatica delle superfici (delle interfacce) sembra essere la logica che tiene insieme, coordina e permette un nuovo tipo di discorsività, cioè di organizzazione e costruzione delle nostre rappresentazioni e descrizioni del mondo: una discorsività architettonica, dotata di caratteri morfologici già abbastanza delineati, la quale, pur non dando luogo a prodotti o manufatti altrettanto individuabili nelle loro funzioni e nel loro ruolo, sembra candidarsi ad assolvere certe precise funzioni culturali e sociali.
In effetti, se ci chiediamo con che cosa, in realtà, abbiamo a che fare, quando mettiamo le mani sul computer, con che ordine di oggetti, di là dalla contrapposizione di ipertesto e database, davvero ci mancano i parametri per una individuazione. Sicuramente sappiamo che il carattere di «memoria pragmatica» del computer sta crescendo a dismisura rispetto ad altre funzioni più antiche: quella di calcolo, che tende a essere dimenticata (chi chiama più il computer «calcolatore»?), che costituisce per così dire il cervello limbico dello strumento; e quella comunicativa, che comunque si è trasformata ed è sempre gremita di oggetti intermedi tra un comunicatore e l'altro, di un fare insieme, di un manipolare documenti, che non è più semplicemente comunicare, ma non è nemmeno il mezzo divenuto messaggio: è invece qualcosa al tempo stesso di relazionale e di estremamente etero–referenziale, che potrebbe chiamarsi con–vivere, community without propinquity. Infine, quel che rimane, quel che si apre ancora a un grande sviluppo, è la memoria operativa, corticale, della rete. Ovvero, in ultima analisi, la sua ipertestualità.
In effetti, se ci chiediamo con che cosa, in realtà, abbiamo a che fare, quando mettiamo le mani sul computer, con che ordine di oggetti, di là dalla contrapposizione di ipertesto e database, davvero ci mancano i parametri per una individuazione. Sicuramente sappiamo che il carattere di «memoria pragmatica» del computer sta crescendo a dismisura rispetto ad altre funzioni più antiche: quella di calcolo, che tende a essere dimenticata (chi chiama più il computer «calcolatore»?), che costituisce per così dire il cervello limbico dello strumento; e quella comunicativa, che comunque si è trasformata ed è sempre gremita di oggetti intermedi tra un comunicatore e l'altro, di un fare insieme, di un manipolare documenti, che non è più semplicemente comunicare, ma non è nemmeno il mezzo divenuto messaggio: è invece qualcosa al tempo stesso di relazionale e di estremamente etero–referenziale, che potrebbe chiamarsi con–vivere, community without propinquity. Infine, quel che rimane, quel che si apre ancora a un grande sviluppo, è la memoria operativa, corticale, della rete. Ovvero, in ultima analisi, la sua ipertestualità.
La forma ipertestuale spinge a una armonizzazione di tre modelli di raccolta, elaborazione e presentazione del sapere: enciclopedico, argomentativo e narrativo. Sono in fondo i tre tipi di discorsività che dominano ancora il nostro universo cognitivo. Ma non basta: essa poi recupera altre forme, mimetiche, iconiche, ludiche, deittiche, diagrammatiche. E infine sviluppa la capacità di pensare e rappresentare contesti plurimi, ibridi, stratificati, fatti di numeri e di corpi, e di spazializzare la loro relazione. Tutto ciò è molto diverso e molto di più di un database, così come è molto di più di unvideogame. Ma è anche più della digitalità stessa.
E proprio osservando alcuni frammenti di questa discorsività realizzata, quelli meglio riusciti, se ne ha la precisa impressione. Sarebbe difficile ad esempio descrivere Il cane di terracotta di Camilleri5 in versione digitale come un «database» oppure come un «videogioco». Certamente è altro. È un ipertesto che coordina e chiama a sé molte funzioni autoriali: un disegno molto accurato, un'esecuzione del testo altrettanto efficace, la sceneggiatura, l'animazione, gli inserti documentali, le musiche originali. Tutto ciò comporta anche aspetti di archiviazione e di gioco, ma sarebbe comunque inesatto mettere in primo piano solo questi ultimi, vista l'armonizzazione particolarmente felice con l'insieme. Così tuttavia definisce l'ipertesto Michael Heim: «From the computer science point of view, hypertext is a database with nodes (screens) connected with links (mechanical connections) and links icons (to designate where the links exist in the text)».6 Sarebbe come dire che il libro è un insieme di caratteri mobili. È un riduzionismo che a volte può essere efficace, ma di cui, a quanto mi sembra, ora non abbiamo affatto bisogno.
Spesso, in effetti, il progetto di un'interfaccia suggerisce più idee sulla costituzione di una base di dati di quante non ne suggerisca la strutturazione di una base di dati riguardo alla configurazione dell'interfaccia. La logica ipertestuale (comporre, delimitare, strutturare, collegare, simulare) impone un rapporto continuo con l'esterno, ha qualcosa di sperimentale, che sembra perfino travalicare il dominio retorico e di mercato. È una forma di adattamento aperto al reale. E perciò è anche, per natura, creativa.
È provato, per fare un esempio su larga scala, che il Web – con la sua logica e il suo funzionamento – abbia influenzato lo sviluppo di database orientati all'oggetto, rispetto ai semplici database relazionali. Un esempio classico, invece, di database che ha determinato – forse troppo – lo stile e la costituzione della superficie, cioè dell'interfaccia, è la LIZ di Eugenio Picchi e Pasquale Stoppelli. Ma di là dalla casistica nostrana, la maggior parte dei manufatti digitali soffre o di uno scollamento delle ragioni dell'interfaccia da quelle della banca dati, o di un'apposizione improvvisata di un'interfaccia gradevole su un database di tutt'altra natura, o, quel che è peggio, della presenza di un'interfaccia gradevole sopra il nulla. Dovrebbe essere ciò che vogliamo ottenere a guidare l'architettonica complessiva di un manufatto digitale, ma il fatto è che non è ancora per nulla chiaro quello che vogliamo ottenere. Allo stesso modo è l'uso culturale che vogliamo fare di un testo che ci può dire come codificarlo, ma ci vorrà forse un secolo per assimilare e comprendere quell'uso possibile, e intendersi sulle ragioni, sulle convenzioni e sulle modalità della cultura digitale. Eppure, se ci sono certezze, riguardo agli oggetti digitali, queste sembrano riguardare una sorta di morfologia, metodologia e fisiologia del pensiero. Potranno cambiare i supporti: il mondo digitale è anzi alla ricerca disperata di supporti che offrano maggiori sicurezze, in termini di durata e stabilità, rispetto a quelli attuali, del tutto inaffidabili; potranno cambiare i canali, attualmente lenti e primitivi; ma certe forme di base sembrano ormai acquisite, così come certe funzioni fondamentali che permettono di «agire» i nuovi tipi di testualità. E inoltre sembrano acquisiti certi meccanismi, certe procedure, certi stili che costituiscono una forma generale del connettere, dell'interrogare, e del disporre: l'ipertestualità sta creando una nuova forma di spazialità culturale, ovvero un luogo dove muoversi nella doppia modalità che si è descritta paradigmaticamente come presenza simultanea di puntatore e cursore.
Le interfacce liquide che si stanno sperimentando ora, a partire da «Aqua», nuovo ambiente di Apple, o certe ambientazioni Flash dove il contesto dinamico si trasforma al passaggio del visitatore, probabilmente tenderanno ad annullare la scissione tra cursore e puntatore, contrassegno fenomenico dell'ipertestualità: il puntatore ridiverrà una presenza più piena, più operativa: costituirà quasi una sorta di «soggettiva» tattile, come avviene già in molti giochi elettronici. Ma se solo la liquidità si interromperà, se si può dir così, un solo istante, allora si sarà di nuovo calati in un ambiente ipertestuale. L'ipertesto è una logica che governa e sorregge molti generi e forme differenti, e possiede una grande forza inclusiva.
Se il semplice fatto che il visitatore sia rappresentato, sullo schermo, da un alter ego virtuale o da due fa la differenza tra scrittura e scena, tra ipertesto e realtà virtuale, è anche vero che l'ipertestualità è una forma di scrittura che contiene la scena, e in certa misura la realtà virtuale. Sembra lo strumento più efficace inventato dall'umanità per permettere l'accostamento non osmotico di differenze.
E proprio osservando alcuni frammenti di questa discorsività realizzata, quelli meglio riusciti, se ne ha la precisa impressione. Sarebbe difficile ad esempio descrivere Il cane di terracotta di Camilleri5 in versione digitale come un «database» oppure come un «videogioco». Certamente è altro. È un ipertesto che coordina e chiama a sé molte funzioni autoriali: un disegno molto accurato, un'esecuzione del testo altrettanto efficace, la sceneggiatura, l'animazione, gli inserti documentali, le musiche originali. Tutto ciò comporta anche aspetti di archiviazione e di gioco, ma sarebbe comunque inesatto mettere in primo piano solo questi ultimi, vista l'armonizzazione particolarmente felice con l'insieme. Così tuttavia definisce l'ipertesto Michael Heim: «From the computer science point of view, hypertext is a database with nodes (screens) connected with links (mechanical connections) and links icons (to designate where the links exist in the text)».6 Sarebbe come dire che il libro è un insieme di caratteri mobili. È un riduzionismo che a volte può essere efficace, ma di cui, a quanto mi sembra, ora non abbiamo affatto bisogno.
Spesso, in effetti, il progetto di un'interfaccia suggerisce più idee sulla costituzione di una base di dati di quante non ne suggerisca la strutturazione di una base di dati riguardo alla configurazione dell'interfaccia. La logica ipertestuale (comporre, delimitare, strutturare, collegare, simulare) impone un rapporto continuo con l'esterno, ha qualcosa di sperimentale, che sembra perfino travalicare il dominio retorico e di mercato. È una forma di adattamento aperto al reale. E perciò è anche, per natura, creativa.
È provato, per fare un esempio su larga scala, che il Web – con la sua logica e il suo funzionamento – abbia influenzato lo sviluppo di database orientati all'oggetto, rispetto ai semplici database relazionali. Un esempio classico, invece, di database che ha determinato – forse troppo – lo stile e la costituzione della superficie, cioè dell'interfaccia, è la LIZ di Eugenio Picchi e Pasquale Stoppelli. Ma di là dalla casistica nostrana, la maggior parte dei manufatti digitali soffre o di uno scollamento delle ragioni dell'interfaccia da quelle della banca dati, o di un'apposizione improvvisata di un'interfaccia gradevole su un database di tutt'altra natura, o, quel che è peggio, della presenza di un'interfaccia gradevole sopra il nulla. Dovrebbe essere ciò che vogliamo ottenere a guidare l'architettonica complessiva di un manufatto digitale, ma il fatto è che non è ancora per nulla chiaro quello che vogliamo ottenere. Allo stesso modo è l'uso culturale che vogliamo fare di un testo che ci può dire come codificarlo, ma ci vorrà forse un secolo per assimilare e comprendere quell'uso possibile, e intendersi sulle ragioni, sulle convenzioni e sulle modalità della cultura digitale. Eppure, se ci sono certezze, riguardo agli oggetti digitali, queste sembrano riguardare una sorta di morfologia, metodologia e fisiologia del pensiero. Potranno cambiare i supporti: il mondo digitale è anzi alla ricerca disperata di supporti che offrano maggiori sicurezze, in termini di durata e stabilità, rispetto a quelli attuali, del tutto inaffidabili; potranno cambiare i canali, attualmente lenti e primitivi; ma certe forme di base sembrano ormai acquisite, così come certe funzioni fondamentali che permettono di «agire» i nuovi tipi di testualità. E inoltre sembrano acquisiti certi meccanismi, certe procedure, certi stili che costituiscono una forma generale del connettere, dell'interrogare, e del disporre: l'ipertestualità sta creando una nuova forma di spazialità culturale, ovvero un luogo dove muoversi nella doppia modalità che si è descritta paradigmaticamente come presenza simultanea di puntatore e cursore.
Le interfacce liquide che si stanno sperimentando ora, a partire da «Aqua», nuovo ambiente di Apple, o certe ambientazioni Flash dove il contesto dinamico si trasforma al passaggio del visitatore, probabilmente tenderanno ad annullare la scissione tra cursore e puntatore, contrassegno fenomenico dell'ipertestualità: il puntatore ridiverrà una presenza più piena, più operativa: costituirà quasi una sorta di «soggettiva» tattile, come avviene già in molti giochi elettronici. Ma se solo la liquidità si interromperà, se si può dir così, un solo istante, allora si sarà di nuovo calati in un ambiente ipertestuale. L'ipertesto è una logica che governa e sorregge molti generi e forme differenti, e possiede una grande forza inclusiva.
Se il semplice fatto che il visitatore sia rappresentato, sullo schermo, da un alter ego virtuale o da due fa la differenza tra scrittura e scena, tra ipertesto e realtà virtuale, è anche vero che l'ipertestualità è una forma di scrittura che contiene la scena, e in certa misura la realtà virtuale. Sembra lo strumento più efficace inventato dall'umanità per permettere l'accostamento non osmotico di differenze.
http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2001-i/