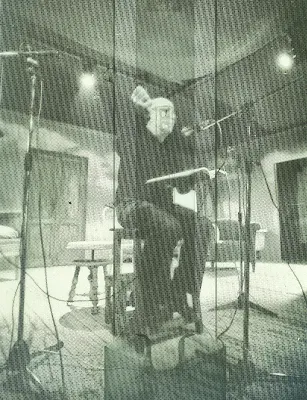«C’era una volta…». Sì, c’è stato un tempo,
neppure troppo remoto – tra gli inizi degli anni Sessanta e la fine dei
Settanta – in cui si credeva possibile rifondare il mondo, trasformando
un movimento di idee in moto di rivolta contro il conformismo, la
sclerosi, le disuguaglianze, la violenza di una società basata sullo
sfruttamento, che marginalizzava il dissenso, espropriava il vissuto. Se
ne legge testimonianza in una rivista ricomparsa da poco, davvero
preziosa per chi, per ragioni anagrafiche, non avesse potuto seguire dal
vivo dibattiti e contrasti, tensioni e contrapposizioni. «Quindici»,
riproposta ora in antologia da Feltrinelli per le cure di Nanni
Balestrini, ne dà articolato riscontro: e davvero conserva piena
efficacia, nella sua totale inattualità, quel dibattito tra ragioni
della letteratura e della politica, della militanza e delle
controculture che si sovrapponevano e convivevano, appassionate ed
estreme.
Crudeltà come appetito di vita
Volevamo la luna, intitola Cortellessa una sua densa e lucida
postfazione, in cui passa in rassegna temi e modi di quel dibattere,
siglato da letterati e giornalisti, artisti, architetti, scienziati,
esponenti dell’antipsichiatria, che rispetta pienamente le intenzioni
indicate nell’editoriale da un Andrea Barbato misurato e caustico:
puntare al «parziale» e al «contraddittorio», promuovere il dubbio e il
disordine, contro l’ordine delle certezze. E si tocca con mano una
distanza, una separatezza, se non proprio uno spaesamento, con tutte le
conseguenze del caso.
Ma non di questo intendo parlare, in una stagione come la nostra che di
Sessantotto, della sua complessità, si sta variamente occupando con
indagini rigorose, ma è anche chiamata a sensibilizzarsi
tempestivamente, con urgenza, per ciò che intorno accade di pericoloso,
di irrimediabile, qui e ora. Voglio dedicare piuttosto questa breve nota
a due collaboratori di «Quindici», per niente occasionali, dal momento
che il primo, Adriano Spatola, ne è redattore fin dal primo numero,
insieme con Giulia Niccolai e Letizia Paolozzi, e il secondo, Corrado
Costa, ne è collaboratore fisso, perlomeno all’inizio, e ne influenza
una linea sadiana e artaudiana: quella della Letteratura della crudeltà
(una crudeltà come appetito di vita, rigore cosmico, necessità
implacabile), se ci si consente di sottrarre il titolo a uno scritto di
Edoardo Sanguineti comparso sul numero d’esordio, insieme con una
provocatoria pagina del poeta-avvocato Costa, Pornolaroid (seguita, nel
secondo numero, da un’altra, Neosade, non meno irriverente, a proseguire
in qualche modo la linea di una letteratura che pratichi – lo indicava
Sanguineti – la «categoria del cinismo violento»).
Nelle zone del non detto
Ciò che Spatola e Costa si propongono di attuare, in modi differenziati
nell’applicazione ma non lontani nelle intenzioni, è la destrutturazione
del linguaggio, l’introduzione di un «disordine» controllatissimo,
eppure esplosivo ed eversivo, che penetra tra le giunture della
sintassi, libera la lettera dallo schema grafico e tipografico e la
poesia dalla separatezza che le preclude interferenze con le arti, il
teatro, la musica, il cinema. Entrambi vogliono dilatare lo spazio della
scrittura, esporla al contatto con il momento visivo e con la voce, con
l’esecuzione, ritenendo la «poesia totale» l’unica maniera – lo scrive
Spatola su «Quindici» sotto il titolo Poesia, apoesia e poesia totale –
di «usare positivamente e concretamente, nella direzione di una utopia
anarchicamente garantita», l’esperienza del linguaggio. Ed entrambi
vogliono poi provocare la «dicibilità» investigando anche le zone del
non detto, delle rifrazioni, del doppio, fino a rendere udibile,
visibile – lo fa soprattutto Costa – il vuoto e l’afasia,
Inutile nasconderlo: non li si conosce, Spatola e Costa, se non in
nicchie di affezionati dell’avanguardia e di estimatori delle sue
propaggini emiliane, localizzabili tra Reggio Emilia e Parma, nella
cittadella perimetrata del Mulino di Bazzano, sorta di corte rurale
protetta di proprietà della famiglia Costa sulla sponda parmense del
fiume Enza. Lì, in un isolamento ancestrale (il telefono a qualche
chilometro di distanza), Adriano Spatola e Giulia Niccolai si ritirano a
conclusione dell’esperienza di «Quindici»: e tengono, sull’ampio tavolo
di cucina, tra profumi di minestrone e spezzatino e aromi di colla e
carta, riunioni redazionali del marchio editoriale Geiger, discutono i
numeri di «Tam Tam», «Baobab», «Cervo volante», fondano una minuscola
tipografia artigianale autogestita, sacerdoti laici di una pratica del
libro-manufatto condivisa da amici dell’Italia e del mondo.
Fin qui la cronaca, gli aneddoti, ricostruiti con discrezione e affetto
da Eugenio Gazzola nel volume fresco di stampa «Al miglior mugnaio».
Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano, uscito presso Diabasis
(pp. 215, euro 17): a quelle pagine rimando, così attente nel definire
il sapore del luogo e lo scandirsi del tempo in cui prende corpo una
scrittura che a poco a poco viene svelata e illustrata, dallo
sperimentalismo degli inizi affidati alla rivistina «Bab Ilu» (due soli
numeri nel ’62) o dalle prove di Zeroglifico, iniziate nel ’65, che si
collocano tra poesia concreta e poesia lineare, azzerando il valore
semantico della lettera per consentirle nuove operazioni di rimontaggio,
fino alla dilatazione della parola oltre i confini del soggettivo e il
perimetro della pagina, per affrontare l’«urto dei nuovi frammenti», da
Diversi accorgimenti (1975) alla Piegatura del foglio (1983), con le
allegorie da fine della storia che le si connettono.
Non è insomma solo l’autore di Verso la poesia totale (1969), Spatola, o
lo sperimentatore (il poeta visivo) che si pone al confine tra
letteratura e arte, o l’esecutore (il poeta corporale) di performances
divenute celebri per le reiterazioni di parole (celeberrima Aviation
aviateur…): è poeta «senza aggettivazione», che il testo di Gazzola
aiuta a riscoprire nella sua intensità, fatta di antimelodia e
ribaltamenti tematici, ritmi giocosi e scacco della rappresentazione,
fino ad accettare la sfida del silenzio o ad affidare al corpo, alla sua
sola presenza, l’atto del comunicare.
Tacere, scriveva Sartre, non è «essere muti», ma rifiutarsi di parlare, e
dunque «parlare ancora». Lo ricorda Simonetta Bondoni in una pagina
dedicata questa volta a Costa, alla sua «cosciente afasia», all’interno
di un volume curato ancora da Gazzola che ne restituisce la fisionomia a
tutto tondo (Corrado Costa, The complete Films. Poesia Prosa
Performance, Le Lettere, collana «fuoriformato», pp. 352, euro 35, con
un dvd di Daniela Rossi). Proprio il poeta-avvocato (difensore di
Tondelli in occasione della denuncia di Altri libertini) si rivela, di
pagina in pagina, il massimo esponente di una scrittura dello
sdoppiamento, della perdita senza recupero di una parola abusata. Nel
rovescio, nel «retro», va indagato, per Costa, il senso abraso: ed è
davvero straordinaria la sua capacità di rendere fisica, attraverso la
negazione, la concretezza di ciò che non viene pronunciato, con la
levità eversiva e l’ironia di un surrealismo giocoso, da patafisico che
smaschera i perbenismi e gli usi strumentali del linguaggio.
Un «signore
degli gnomi», chiosava con la consueta acribia critica Alfredo Giuliani
ricordandolo sulla «Repubblica» il 12 febbraio 1991, a tre giorni dalla
morte: una «creatura leggera» che si dilettava «a scrivere, a vivere,
con grande intelligenza, sensibilità, compostezza, ironia».
Un grande dilettante
Auspicava, Giuliani, che qualcuno raccogliesse in volume tutte le sue
poesie per conservarne – scriveva – «le scintille, il garbo spiritoso,
le malinconie festose».
È stato fatto. E fa bene al cuore rileggerlo e
riascoltarlo, il poeta dello Pseudobaudelaire (1964), delle Nostre
posizioni (1972), di The Complete Films (1983), «fool amabile e
inaffidabile», secondo Cortellessa: poeta e basta, da apprezzare
nell’irriducibilità del suo volerci convincere, «testoni» che siamo, a
sollevare la superficie, per scoprire, insieme con l’insopportabilità
delle «ferite narcisistiche», il rovescio delle apparenze (l’«enigma
della vita, l’assenza, il buco al cuore che ci portiamo dentro», scrive
Giulia Niccolai).
Rileggerlo come «grande dilettante», saggista, vignettista, scrittore di
teatro, per cogliere quel suo «vuoto lasciato pieno» (così Balestrini
nella poesia A Corrado) e cautelarci intanto dalle semplificazioni,
dall’omologazione. Parliamone, di Costa e di Spatola, perché non è tempo
di clandestinità per il pensiero.





![[videorlab] Costa e Spatola in redazione Miniatura](https://i1.ytimg.com/vi/FkNfkeC4zow/default.jpg)